Alle tre e mezzo della notte, quando il sonno è più profondo e sgradevole il risveglio, bussarono alla porta della baracca N°7, tre colpi secchi ravvicinati, perentori, poi altri tre dopo una breve pausa. Morelli, nel destarsi, capì subito che si doveva trattare di una disgrazia.
Infatti, nel tunnel numero due una roccia era caduta sulla squadra del fronte di avanzamento. Un minatore era rimasto schiacciato.
L’avevano portato fuori dal tunnel su un vagone, e l’avevano caricato ancora vivo sull’ambulanza del cantiere.
L’infermiera aveva subito detto che le sue condizioni erano molto gravi, e bisognava trasportarlo d’urgenza all’ospedale, in città, se si voleva avere qualche speranza di salvarlo.
Con il benestare di Morelli l’ambulanza partì immediatamente, ma prima ancora di arrivare a San Fernando, un pneumatico si ruppe malamente sulla strada pietrosa.
La ruota di scorta non c’era.
L’aveva presa, la sera prima, Maximiliano Iturbide, responsabile del Dipartimento della Sicurezza del Lavoro, che se l’era fatta consegnare dall’autista per andare in paese a trovare una ragazza.
Il minatore morì dopo un’ora sulla strada, confortato dall’infermiera che piangeva in silenzio, mentre l’autista si dirigeva a piedi a San Fernando, facendo rotolare la ruota sgonfia, in cerca di un gommista.
Poche ore dopo, Morelli firmò il licenziamento in tronco di Iturbide, che non era ancora tornato dalla sua scorreria amorosa.
Suarez cercò timidamente di persuaderlo a prendere provvedimenti meno drastici.
In fondo, asseriva, Iturbide era una brava persona, loro due avevano lavorato insieme molti anni anche in altri cantieri e non si era mai comportato così.
Ma Morelli non volle sentire ragione e mantenne la decisione presa.
Passarono alcuni giorni, finchè il lavoro si fermò nel tardo pomeriggio per il riposo del fine settimana.
Erano le sei e mezza del venerdì e faceva ancora un caldo infernale.
Nella valle del cantiere non tirava un filo di brezza.
Famiglie di asini sostavano immobili negli scarsi spiazzi disponibili, incuranti persino dei tafani più assetati di sangue che svolazzavano ronzando attorno alle loro teste.
Morelli, che era giunto da poco dal cantiere, si trovava fuori della sua baracca, seduto su uno sgabello di legno, con la schiena appoggiata alla parete, in pantaloni corti e canottiera.
Guardava la sua gente in movimento, frettolosa di evadere dal cantiere e ritornare alle proprie case.
Dopo essersi cambiati i vestiti del lavoro uscivano dalle baracche con le sacche in spalla e correvano vociferando verso il piazzale degli autobus, dove i vecchi automezzi li attendevano con i motori accesi.
Morelli pensava al telefono, che anche la settimana trascorsa non era stato allacciato, e che gli avrebbe permesso di uscire da quel posto almeno virtualmente, per pochi minuti, se non fisicamente come si accingevano a fare tutti gli altri.
E invece niente, niente telefono, niente ricambi, niente comunicazioni… Lui sarebbe rimasto là, semplicemente perché non aveva dove andare.
O, per meglio dire, le sue radici a diecimila chilometri non erano raggiungibili in un fine settimana, e tanto meno senza l’ausilio del telefono, sui cui fili e cavi sottomarini la voce può correre quasi alla velocità della luce.
Assorto nei suoi pensieri stava sorseggiando una birra tiepida direttamente dalla canna di una bottiglia di vetro marrone, smerigliata dagli innumerevoli riutilizzi.
Da dietro la bottiglia vide arrivare Iturbide, procedeva con passo barcollante.
Evidentemente era ubriaco, dopo aver preparato la sacca per l’ultima volta aveva fatto il pieno di tequila e birra. Quando fu giunto a pochi passi da lui, Iturbide estrasse una pistola che portava sotto alla camicia, infilata nella cintura dei pantaloni, e mise il colpo in canna.
Teneva gli occhi socchiusi, e disse: “Sono venuto a dare l’addio prima di andarmene” Morelli credette fosse giunta la sua ora, invece… .“
Non ce l’ho con lei, che ha fatto la sua parte, ce l’ho con questo vigliacco figlio di puttana che non ha saputo difendermi, sebbene lavorassimo insieme da tanti anni.
Adesso gli innaffio la stanza col mio piombo”.
Vuotò il caricatore contro la stanza di Suarez, che per sua fortuna era già partito da qualche ora (venerdì era sempre il primo a sparire, adduceva che sarebbe passato a fare delle commissioni utili per il cantiere).
L’eco moltiplicò i colpi.
Dall’interno della baracca provenne il rumore di vetri infranti.
Poi fu silenzio.
Bonfanti, nella baracca a fianco, si stava radendo davanti allo specchio.
Sentì un rumore secco provenire dalle tavole della parete alle sue spalle, si girò e vide qualcosa per terra che ruotava su se stesso.
Si chinò a raccoglierlo, era una pallottola da 9 millimetri ricoperta di rame lucido.
La guardò da vicino tenendola fra l’indice e il pollice, scottava ancora.
“Ma guarda che roba!” disse Bonfanti, poi posò la pallottola sul portasapone e riprese a radersi.
Iturbide se ne andò, barcollando come prima ma molto soddisfatto di se perché aveva agito da uomo onorato e senza finire in una infelice galera messicana.
Nessuno lo rivide più in cantiere.
Morelli finì di vuotare la bottiglia, poi col dito mignolo fece il gesto di stapparsi l’orecchio destro che gli fischiava per gli spari esplosi a distanza ravvicinata.
I buchi nelle pareti delle baracche rimasero fino alla fine del cantiere, lasciando passare raggi di sole che illuminavano le particelle di polvere danzanti nella penombra, confermando la teoria dei moti browniani a chi li osservasse nei momenti di ozio.
Autore: Franco Garelli
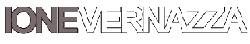
Scrivi un commento