Durante il lungo viaggio in aereo, in classe economica, Morelli bevve tutto il vino che riuscì ad ottenere dalla hostess, ovvero un paio di piccoli bicchieri, finché si addormentò pacificamente nell’angusto sedile mentre le ore passavano ed i chilometri scorrevano a migliaia sotto di lui. Non sentì neppure i vagiti del bambino di pochi mesi che veniva allattato pochi sedili dietro di lui, ne’ la coppia di napoletani che discuteva senza sosta ad alta voce al suo lato. Finché l’altoparlante emise in cabina l’ordine di allacciare le cinture di sicurezza e posizionare verticalmente le spalliere delle poltrone, e l’aereo atterrò sulla pista di arrivo vibrando da cima a fondo.
All’aeroporto di Città del Messico trovò ad aspettarlo un autista con una macchina della Società, che, per farsi riconoscere, teneva in mano un cartello di cartone con il nome del cantiere.
Il viaggio era lungo, disse l’autista: sette ore per percorrere meno di duecento chilometri, Dio permettendo.
Nelle prime due ore di viaggio percorsero strade pavimentate, ampie e rette, che attraversavano una pianura costellata di collinette vulcaniche ricoperte di sterpaglie secche.
Il cielo era terso e nitido, e una luce abbagliante feriva gli occhi, costringendo Morelli a strizzarli continuamente. Passarono diverse cittadine e villaggi, nei cui centri il traffico era rallentato e perfino congestionato per la presenza di vecchie macchine e sgangherati carretti tirati da asini indolenti. Più avanti il paesaggio cominciò a cambiare: avvicinandosi alla zona del cantiere, la strada si fece polverosa e stretta, e iniziò ad inerpicarsi in una regione montagnosa.
Dopo molti chilometri, molte ore e molte curve, giunsero in un paese con la strada principale lastricata e le case di pietra e legno. Non aveva l’aspetto dei paesi messicani che avevano attraversato quel giorno, con le case basse imbiancate di calce e circondate da siepi di fichi d’india, aveva piuttosto un che di europeo in stile ottocentesco.
Faceva freddo, evidentemente a causa della quota, infatti i camini delle case fumavano.
L’autista disse che quel paese si chiamava San Fernando, ed era stato fondato nel 1625 dagli Spagnoli che erano venuti a cercare oro e argento nelle montagne circostanti. A riprova delle sue parole, nella piazza principale si ergeva una antica chiesa in stile barocco, costruita in pietra rossiccia, le cui dimensioni di cattedrale sembravano fuori luogo in quel paesino di poche anime, e testimoniavano un passato opulento, e la volontà di marcare un territorio con i simboli della propria cultura. Non a caso, come spiegò l’autista, quella chiesa cristiana era stata edificata dagli indios schiavizzati sulle rovine di un tempio pagano.
Quello era l’ultimo avamposto della civiltà prima di affrontare il cammino che li separava dal cantiere, perciò fecero rifornimento di benzina, bevvero una tazza di caffè e ripartirono, imboccando una valle rocciosa, incassata fra pareti scoscese.
All’approssimarsi del tramonto la luce si ammorbidiva, permettendo a Morelli di osservare le rocce, che poco prima lo avrebbero abbagliato. Sugli strapiombi rocciosi, ormai quasi verticali, si affacciavano le gallerie di antiche miniere. Alcune imboccature erano semicircolari, o a ferro di cavallo, ma la maggior parte aveva forme irregolari, come di antiche spelonche. Da queste aperture colavano verso il basso, macchiando le pareti di roccia, sbavature giallastre e brune di liquami minerali ossidati dai secoli.
In tempi remoti, impalcature da brivido addossate alle rocce dovevano permettere l’accesso a quelle gallerie mediante fragili scale a pioli. Da buon tecnico, Morelli si immaginò il brulichio di minatori in equilibrio precario su quelle impalcature fatte di tronchi grezzi, e sentì un brivido percorrergli la schiena.
Quanti, trasportando sulle spalle il cesto ricolmo della roccia scavata all’interno, erano scivolati e precipitati nei baratri?
Ormai le ombre, inerpicandosi dal fondo valle, sgorgando dagli orridi e dalle forre, allargandosi dagli anfratti oscuri, si riunivano vittoriose e, prorompenti, ricacciavano la luce sempre più verso l’alto, sui pinnacoli brillanti che merlavano le gole. Alla desolazione naturale di quei luoghi si aggiungeva una sensazione di angoscia, come se le montagne stessero urlando senza voce, da quelle bocche spalancate da secoli sui baratri, tutto il loro dolore per essere state violate dagli uomini, derubate e sviscerate nelle loro profondità.
L’autista parlò, lentamente, senza distogliere lo sguardo dalla strada pericolosa, spiegando che quelle miniere le avevano aperte i Conquistadores Spagnoli a partire dai primi anni del Sedicesimo Secolo. Morelli si riscosse, e ripensò allora alle centinaia di Indios che dovevano aver consumato le loro vite in quella valle. Nessuna lapide certamente ricordava il loro sacrificio. Del resto, quale artista avrebbe saputo concepire un monumento alla loro sofferenza più tragicamente espressivo di quel paesaggio che loro stessi involontariamente avevano contribuito a straziare?
Ormai l’automobile procedeva molto lentamente. Era quasi buio, la strada era scesa al fondo di una gola e arrancavano sui ciottoli del greto di un torrente, dove la scarsità d’acqua permetteva il transito della macchina scricchiolante. Quella era l’unica via di accesso al cantiere. Sempre quando non piovesse, ed il torrente diventasse tumultuoso nel giro di pochi minuti, a causa della mancanza di terra e vegetazione che trattenessero l’acqua piovana. Le pareti levigate dall’acqua e massi di enormi dimensioni recentemente spostati, davano l’idea di una violenza rabbiosa ed ostile, pronta a risvegliarsi all’improvviso. Evidentemente la natura si vendicava ancora degli immani, antichi disboscamenti perpetrati alla ricerca di sempre più legname per le armature delle gallerie ed i forni per l’ arrostimento dei minerali e la fusione dei metalli estratti.
Dopo un lungo silenzio l’autista parlò di nuovo, per dire che nel luogo dove si trovavano, secoli prima gli Indios erano riusciti a tendere un’imboscata agli Spagnoli, massacrandone alcuni. Il luogo si prestava, pensò Morelli, ed immaginò la pioggia di pietre e frecce su quella gente barbuta che un po’come lui se ne andava in giro per il mondo a fare danni, col pretesto di portare la civilizzazione ed il vero credo a chi se ne stava bene per conto suo. Ad onor del vero una differenza, e non da poco, fra lui ed i conquistatori c’era: lui non pretendeva di cambiare le credenze e le usanze altrui, ed addirittura non credeva poi tanto neppure nell’utilità delle opere alla cui realizzazione partecipava. In quel momento gli vennero in mente le parole di una canzone che aveva ascoltato: “one should never stay where he doesn’t belong”.
Osservando il luogo, non poté evitare di pensare anche quanto sarebbe stato facile per dei briganti appostati prendere d’assalto la macchina e fuggire con le loro cose dopo averli trucidati entrambi.
Procedevano lungo il torrente quasi a passo d’uomo, fra continui scossoni, con il motore al minimo, quando si trovarono davanti un gruppo di asini che ostruivano il passaggio. Gli asini rimasero fermi dove si trovavano, incuranti di ripetuti colpi di clacson, finché l’automobile li urtò, aprendosi il varco spingendoli di lato. “Sono i discendenti, ormai allo stato semibrado, degli asini utilizzati dagli antichi minatori. Ormai non servono più, danno solo fastidio” spiegò l’autista. Morelli guardò gli asini dal finestrino al riverbero della luce dei fari: gli animali erano rimasti perfettamente immobili ed impassibili, all’automobile non rivolgevano neppure lo sguardo, come se il suo passaggio non li riguardasse. Come se stessero vivendo in un altro tempo, in un altro mondo dove le automobili, la velocità e la fretta non fossero ancora arrivate.
Oltre, in una spianata che sovrastava il torrente, dove la gola cominciava ad allargarsi lasciando intravvedere le stelle, Morelli credette di scorgere una costruzione a forma di piramide, alta meno di una diecina di metri. Intorno, sagome nere di cactus ramificati ricordavano figure umane. Spettri aztechi a guardia dell’altare di qualche dio sanguinario che esigeva sacrifici umani.
Morelli rabbrividì ancora, e cercò di rassicurarsi guardando l’autista: continuava ad essere tranquillo. Si chiamava Miguel, i colleghi lo chiamavano Miguelito. Aveva passato i cinquant’anni, e gli scorreva sangue indio nelle vene. Il volto, dalla pelle scura, era solcato da profonde rughe e dotato orgogliosamente di un bel paio di baffoni. Nonostante si trovasse alla guida e facesse buio, portava un cappello texano beige, gualcito e logorato da anni di uso. Quando parlava, per concentrarsi meglio, con la mano destra si lisciava i baffi.
Infine, giunsero, in piena notte, all’accampamento del cantiere, che era l’unico insediamento umano di una certa rilevanza nel raggio di decine di chilometri.
Autore: Franco Garelli
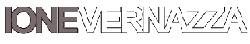
Scrivi un commento