Dedicato a Me Stesso
Preambolo:
I personaggi viventi di questo scritto sono:
• Io stesso (secondo la natura umana, mi assegno il ruolo di protagonista)
• Due signorine (forse compiacenti)
• Un cavaliere (comparsa)
• Un tafano (essere dignitoso sopraffatto da esseri piu’ deboli di lui, ma coalizzati ed organizzati)
• Le formiche che si mangiano il tafano morente
• Una lucertola con la coda azzurra (nome scientifico: Liolaemus Tenuis)
• Un gustoso vermetto dei funghi
Il protagonista dei personaggi inanimati e’ un fortino di cemento armato risalente ai tardi Anni Trenta.
Fatta eccezione per il protagonista vivente, i personaggi non sono importanti, come del resto non lo e’ neanche questo breve racconto, che della banalita’ dei fatti e dei pensieri fa il suo fondamento.
I fatti:
E’ domenica. Dopo mesi di battaglia ininterrotta e senza quartiere, finalmente oggi mi sono fermato a fare una pausa. Ho “abbandonato al suo destino”, per un giorno solo, intendiamoci, il cantiere che dirigo da qualche mese nel sud del Cile. Il cantiere non e’ dei piu’ piccoli: 3.000 operai, diga e centrale idroelettrica sotterranea. Siamo in ritardo sul programma, la pressione e’ altissima, le difficolta’ sembrano insormontabili.
Il cantiere non si ferma mai, di giorno, di notte, di sabato o domenica. Si lavora freneticamente, sotto stress, cercando di fare meglio ma senza riuscirvi. Questo per alcuni di noi responsabili non e’ piu’ lavoro nel senso comune che si attribuisce al termine, ma qualcosa che sconfina nell’ossesione e nel fanatismo. Mi ricorda addirittura una situazione bellica. La Ritirata del Don, o la Battaglia di Stalingrad, direi, vista l’ineluttabilita’ dell’insuccesso che fa seguito ai nostri sforzi ed alla nostra inutile abnegazione.
Qualche giorno fa, su un fronte di lavoro, parlavo con un assistente italiano, alla fine della conversazione, dopo un attimo di silenzio, mi ha guardato, poi ha detto sottovoce:
“Ingegnere, domenica vorrei andare in paese a comprare delle lamette. Ormai sembriamo due partigiani.”
La mente e’ alienata dal lavoro. Uno si ricorda di se stesso quando alla sera giunge in baracca, pochi minuti prima di addormentarsi, salvo risvegliarsi rimuginando le preoccupazioni di lavoro una volta smaltita la stanchezza. Di solito questo succede dopo le tre.
Oggi e’ una domenica mattina speciale, dicevo. Appena sveglio, ho deciso di uscire dall’accampamento, dove normalmente risiedo con i miei colleghi, e mi sono incamminato verso la montagna.
La montagna che mi richiamava da tre anni, avvolta in boschi centenari, protetta sovente da nebbie e vapori. Ha un che di nobile e di magico, come in certe fiabe.
I locali la chiamano “La Pepa”. A volte La Pepa e’ gaia e splendente, come oggi, a volte e’ corrucciata, allora si incornicia di nuvoloni grigi. Una volta ha persino fatto finta di essere un vulcano attivo, simulando il fungo dell’eruzione con dei nembi vorticanti. Di fatto, un lago situato proprio dietro la vetta e delle colonne basaltiche visibili da qua sotto testimoniano un passato non del tutto tranquillo, confermato anche dalla presenza di un vulcano attivo a pochi chilometri.

Sono partito, a digiuno, solo e senza portare altro che il mio mezzo toscano bruciacchiato e puzzolente. Ed una scatola di fiammiferi per accenderlo di tanto in tanto. Niente cibo e niente acqua. In quanto al programma, ho deciso semplicemente che ritornero’ quando ne avro’ voglia.
Passando davanti alla lavanderia ho salutato la signorina che fa le pulizie, dicendole che sarei andato per boschi.
“Ingegnere non si perda, e stia attento alla lupa.”
E rideva… rideva…
Secondo me, non deve mancare tra i miei chi le allunga 20 o 30 dollari per una mezz’ora di affetto, ogni tanto. Tutto fa e “l’uomo non vive di solo pane” diceva un mio vecchio minatore.
Non ho ancora percorso duecento metri che mi imbatto in una quercia antica, con il tronco scolpito dai secoli e percorso da rughe come il viso di un vecchio venerando. Mi fermo ad osservarla con il rispetto che si dovrebbe ai centenari. Non l’avevo mai notata durante le settecentottantasei volte che le ero passato davanti in macchina, ansioso di arrivare a destinazione, ossia: il cantiere alla mattina, il dormitorio alla sera. Va anche detto, a difesa del mio spirito di osservazione, che la maggior parte delle volte che sono passato da qui, al mattino era ancora buio, alla sera era gia’ buio.
All’incrocio fra la stradina dell’accampamento e la strada asfaltata si e’ fermato un autobus di campagna. Ne e’ scesa una signorinetta: bruna, alta un metro e sessanta, di belle forme, ben vestita con roba attillata. Poteva essere colombiana. Portava con se’ solo una borsetta. Con quel bagaglio, si capisce che non si fermera’ molto nell’accampamento. Sicuramente, anche lei viene a vendere affetto. Trovo strano che arrivi a quest’ora, ma del resto c’e’ tra i miei chi di notte fa il turno in cantiere, dalle sette di sera alle sette di mattina.
Frugando nella tasca del giubboto scopro di avere dimenticato di togliere il radio-telefono. Quassu’ non puo’ funzionare, perche’ non c’e’ copertura di rete. E’ solo un peso inutile. Oggi pertanto nessuno potra’ intromettersi nella mia vita senza bussare, col solo premere dei tasti per marcare il numero che mi contraddistingue in rete da altri miliardi di utenti. I numeri di telefono che ci vengono assegnati mi ricordano quei numeri tatuati sul braccio dei prigionieri negli anni ’40, in Germania. Il mio e’: 50068866.
Ti chiamano, ed i tuoi pensieri sono interrotti bruscamente, i tuoi occhi non vedono piu’, le tue orecchie devono ascoltare quello che ti dicono loro, non quello che hai intorno. Improvvisamente sei altrove, oltre la tua volonta’.
Magari stavi guardando una bella donna, o ascoltando musica, o parlando con tuo figlio, o a un Dio. A volte fa anche piacere. Spesso fa anche comodo. A volte invece no, e l’apparecchio suona mentre stai mangiando, o mentre fai i bisogni, in bagno.
Drin drin drin: molla tutto. Pronto! Eccoti la mia attenzione! In ascolto!
Finalmente, dopo chissa’ quanto tempo, oggi sto facendo qualcosa senza uno scopo, sto procedendo senza una meta, dove mi portano le gambe.
Da solo.
Non mi sono neppure preposto di raggiungere la vetta, da cui certamente godrei un panorama fantastico data la nitidezza della giornata e l’altezza della Pepa (la stimo in 1.500 metri).
Non cerco funghi, ne’ resti archeologici, ne’ minerali, ne’ fossili. Niente di niente.
Ora, come da molto tempo non succedeva, la mia mente non pensa al lavoro, ne’ alla fine imminente della nostra civilta’ che ha divorato quasi tutto quello che si poteva. La mente e’ sgombra da pensieri “utili”, produttivi. E’ come un uccello selvatico, che, dopo essere stato rinchiuso a lungo in una piccola gabbia, venga rimesso in liberta’. Allora muove alcuni passi incredulo, guardandosi attorno con circospezione. Poi prende il volo, librandosi nel cielo da tempo dimenticato.
Ora sono assolutamente libero come quel pennuto.
Sono padrone del mio tempo e dei miei sensi.
Non devo mediare con nessuno per decidere le azioni da compiere e quelle da non compiere.
Nessuno sa dove mi trovo. La mia sopravvivenza dipende esclusivamente dalle mie forze, se mi rompessi una gamba o mi mordesse un serpente dal veleno mortifero, o il cuore soccombesse alla fatica, nessun medico e nessuna ambulanza mi soccorrerebbero, ne’ potrei chiedere aiuto. Avevo gia’ provato questa consapevolezza durante le mie passeggiate in Africa, dove i pericoli erano molto piu’ reali e si chiamavano leoni, leopardi, babbuini, licaoni, serpenti come il cattivissimo mamba, la vipera soffiante ed il cobra sputacchino. Per citarne alcuni. (Alcuni asseriscono persino in Africa ci si puo’ ancora imbattere nel terribile Mkele Mbembe.)
Qui non mi servono denari, ne’ l’automobile, ne’ alcun altro amenicolo di quelli che la “civilta” dei consumi ci convince di dover comprare per raggiungere la felicita’ e sentirci alla pari coi nostri simili.
Ed infatti sono felice cosi’. Indubbiamente felice. Sono entrato in uno stato d’animo speciale, che mi permette di apprezzare la solitudine, l’autosufficienza, la lentezza ed i dettagli insignificanti delle cose. E mi viene l’ispirazione di fissare queste sensazioni ed i pensieri che ne scaturiscono. Rimpiango di non aver portato un taccuino all’uopo, pero’ … a pensarci, il telefono e’ di quelli che fanno anche le fotografie e registrano i suoni.
Mi metto a registrare la mia voce, pensando di riascoltarla in seguito per mettere giu’ degli appunti, per non dimenticare cosa si prova ad essere liberi, seppure per un tempo breve.
Ed ecco, dunque, cosa ne viene fuori ora che trasformo i suoni in simboletti neri. Continuo ad usare l’indicativo presente, anziche’ il passato come forse tecnicamente corrisponderebbe, perche’ con questo tempo ho registrato i miei pensieri.
Se avessi la possibilita’ di confrontare ogni singola mia frase con tutto quanto pensato, o detto , o scritto dall’inizio della storia, scoprirei senza ombra di dubbio di non avere inventato nulla di nuovo od originale. Tutto e’ gia’ stato scritto, o detto, o pensato.
Autore: Franco Garelli
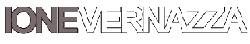

Scrivi un commento