Non scrivo per guadagno, perche’ non sono uno scrittore, sono un ingegnere minerario.
Non scrivo per gli altri, tanto ormai pochi leggono, pochi ascoltano, molti scrivono e tutti dicono la loro opinione. Che considerano infallibile. Che deve essere sparata ai quattro punti cardinali nel minor tempo possibile, pigiando dei tasti.
No. Adesso scrivo per Me.
Scrivo per il piacere di farlo, senza fretta e senza impegni.
Se qualcun’altro un giorno leggera’ queste note, che si addicono a maggiori di quarant’anni, forse potra’ trarne spunto per qualche riflessione. Con molta probabilita’ considerera’ riprovevoli ed intrise di cinismo alcune affermazioni.
Comunque sia, non mi interessa raccogliere consensi ne’ convincere nessuno, io stesso non sono convinto di niente e non ho idea che non possa cambiare, anche se ho fatto l’abitudine a certe idee, il che assomiglia molto ad avere delle convinzioni… Inutile negarlo!
Da tempo non mi accingevo a scrivere qualcosa di personale che segua un filo abbastanza lungo, che riassuma fatti e pensieri, diverso da una relazione di lavoro od un contratto. Ho gia’ detto che sono un ingegnere, e nel nostro mestiere e’ bravo chi si fa capire con poche parole.
Fin da bambino, quando frequentavo le elementari, sono stato abituato a ragionare bene prima di scrivere un tema, un riassunto o una lettera, preparandomi uno schema, dapprima mentale, poi una brutta copia, da trascrivere infine in una “bella copia”, quella ordinata e senza correzioni, che avrebbe letto e corretto il maestro, o il destinatario lontano.
Oggi non e’ piu’ cosi’. Si puo’ buttare giu’ di tutto senza pensare un ordine, tanto poi con il computer si fa il “copia e incolla” e c’e’ sempre tempo di cambiare, riordinare e correggere. Anzi, il computer stesso, fino ad un certo punto, si incarica anche delle correzioni ortografiche. Qualcuno ne deduce che non sia piu’ necessario sforzarsi a studiare la grammatica.
Succede qualcosa di analogo con la fotografia: quando ero ragazzo la pellicola costava soldi, e conteneva solo 12 o 24 pose, eccezionalmente 36. In genere, per risparmiare erano in bianco e nero. La macchina fotografica andava regolata manualmente, scegliendo con attenzione l’apertura del diaframma, il tempo e la messa a fuoco in funzione di ogni situazione particolare di luminosita’, distanza e tipo di inquadratura. Non si scattava mai in vano. Quando il fotografo ci consegnava le stampe delle nostre foto eravamo orgogliosi di quelle venute bene, ci erano costate fatica. Poche venivano male. Oggi fare una o mille foto costa lo stesso, la macchina fa quasi tutto da sola. Basta comprarla e pigiare lo scatto. Non c’e’ bisogno di sapere come funziona una lente o un diaframma. Si possono fare 100 foto e sceglierne 10, le migliori. Buttare via le altre. Oltretutto le foto conservate si possono ritoccare, correggendone i difetti, mediante appositi programmi alla portata di chiunque abbia un computer.
Il dettaglio non si cura piu’. La fretta e la quantita’ hanno preso il posto del piacere di fare le cose bene e con calma. Regalo del consumismo.
Da tempo ho rinunciato a fare foto per immortalare e rivivere bei momenti o belle viste. I momenti vanno vissuti, non si possono conservare. Mentre ti distrai per immortalare, nell’anelito di catturare il piacere indefinitamente, di incantesimarlo, ti sfugge in gran parte l’emozione del momento. Ti sfugge per sempre.
Cammino da mezz’ora, ho percorso un paio di chilometri su una strada sterrata. Passo un vecchio ponte di tronchi sotto al quale scorre un piccolo fiume allegro e spumeggiante come una coppa di Prosecco appena versata. Il suo letto e’ ingombro di grosse rocce chiare, contro le quali si rompe con frastuono la corrente tumultuosa. Viene giu’ dalle pendici della montagna, attraverso boschi antichi. E’ acqua limpida e fresca.
La giornata e’ radiosa, la luce del sole a questa latitudine e’ tagliente, ed accende il verde esaltandone la vitalita’. Ovunque e’ vita fremente, persino il fiume prende vita anche se la sua non e’ vera vita perche’ lui non muore mai, neanche d’estate.
Adesso io sono parte di tutta questa vita qui. E sono alla pari con le altre creature. Se saltasse fuori il leone di montagna dovrei affrontarlo con le mie deboli mani e lui mi mangerebbe senza complimenti, lasciando qualche osso, qualche straccio lacero e senz’altro i vecchi scarponi di similcuoio e gomma. Oltre ad essere duri, puzzano.
Mentre penso al leone, mi accendo il toscano. Accendere un toscano non e’ un gesto banale come accendere una sigaretta, bisogna saperlo fare, fermandosi, ruotando lentamente il bordo alla giusta distanza dal fuoco del fiammifero. L’odore forte del fumo si mischia con l’odore del bosco, e vi si sovrappone. Sovente associo quest’odore acre al ricordo delle mie antiche passeggiate domenicali nel Parco della Pellerina, a Torino. Allora ero allievo del Politecnico, e sovente passavo le domeniche in quella bellissima citta’, da solo, mentre i compagni di studio affrontavano viaggi in treno che duravano alcune ore, per vedere le fidanzate, andare a sciare e fare tutto cio’ che si dovrebbe fare a vent’anni. Mi svegliavo un’ora piu’ tardi del solito, facevo colazione con calma, trovandola migliore anche se era la stessa degli altri giorni. Poi studiavo qualche ora finche’, dopo mangiato, girovagavo senza fretta e senza meta per i viali del parco, osservando la gente e fumando di tanto in tanto il mio sigaro da vecchi. Mi mancava il bastone di legno col manico ricurvo. Imparavo gia’ allora a contare su me stesso.
Svolto a sinistra, verso un sentiero che si inerpica, costeggiando dapprima il fiume ed inoltrandosi poi nei boschi. La luce e’ filtrata dal fogliame spesso. Mi fermo ad osservare dettagli insignificanti: un insetto che cammina su un tronco; un sasso verde levigato dall’acqua (come sara’ giunto qui?); un pezzetto di carbone che affiora dall’argilla della scarpata, testimone di un antico incendio non visto dagli uomini. Giochi di luce e di colori che nessun artista saprebbe riprodurre.
Mi giunge un rumore che alle prime non riconosco, misto di fruscio e colpetti sul terreno. Qualcosa sta arrivando, e’ dietro la svolta del sentiero. Il leone di montagna? Il Mkele-mbembe? L’orco?
No. Appare invece un cavaliere, col suo vestito charro (1). L’uomo avra’ passato la settantina. Ci salutiamo nella sua lingua, poi lui mi domanda dove vado da solo per quei luoghi.
Cammino senza una meta
Dall’altra parte, dietro a quel colle, c’e’ un magnifico lago di montagna, a 5 ore di cammino
La ringrazio, buon uomo, per l’informazione
Che le vada bene
E lui riparte con calma. Alcuni tafani seguono il cavallo, uno si interessa al mio braccio. Lo spiaccico con una manata, mi spiace per lui che non se l’aspettava, ma in natura (come nelle societa’ umane e non), vince il piu’ forte. Piu’ forte puo’ voler dire piu’ grande, o piu’ subdolo, o piu’ velenoso, o debole ben coalizzato con altri deboli, o piu’ intelligente, o piu’ veloce, o piu’ furbo. Caso per caso, non esiste una regola universale per definire il piu’ forte. Il piu’ forte e’ quello che riesce a spuntarla in barba agli altri. Lui, sopravvivendo, sara’ quello che fara’ i figli che ereditano il suo carattere di sopravvivente meglio adattato al suo ambiente. In Italia sopravvivono i furbi, siamo diventato un popolo di furbi guidato da furbi, per esempio. (Puo’ darsi che cio’ ci faccia sopravvivere come individui, ma ci fara’ soccombere come popolo.)
Intanto il tafano si risveglia per terra e cerca di rimettersi in sesto, ma le formiche gli sono gia’ addosso. Vittoria di esseri piu’ piccoli si, ma coalizzati bene.
Il tafano si dibatte negli ultimi spasimi, infine muore, vinto dai pungiglioni e dalle pinze delle assalitrici impietose. La sua morte non fa pieta’ ne’ orrore a nessuno qui intorno. Anzi, nella sua agonia c’e’ qualcosa di dignitoso.
Siamo noi uomini che abbiamo orrore della morte.
Ed abbiamo orrore della solitudine.
Ed abbiamo ancora piu’ orrore di morire nella solitudine. “E’ morto solo come un cane” si dice a volte di qualcuno, scuotendo tristemente la testa.
Solo naci y solo me voy a morir.
(Solo nacqui e solo morirò)
Questa frase la imparai dall’incaricato della sicurezza industriale, nel 1993, in un remoto cantiere del Messico centrale, alcuni giorni prima che lui scaricasse tutto il caricatore della sua 9 mm parabellum a pochi centimetri dalla mia faccia, contro la baracca del suo capo, colpevole di non averlo difeso dal mio ordine di licenziarlo. Pedro Lopez si chiamava. Qualche settimana prima mi aveva prestato quella stessa pistola per andare a negoziare col propietario del terreno su cui avrebbe dovuto sorgere l’impianto di vagliatura delle ghiaie, ed un’altra volta per dare il colpo di grazia ad un asino con una orribile frattura esposta. Ma questa e’ un’altra storia che qui non c’entra per nulla, salvo registrare che il tafano me l’ha riportata alla memoria attraverso la concatenazione dei pensieri anteriori. Come corre la mente in queste ore …
Questo tafano qui non fara’ piu’ figli, ed il suo carattere genetico di voler pungere il mio braccio invece del culo del cavallo non si ripetera’ in alcuna prole. Peggio per lui.
Solo naci y solo me voy a morir. Solo nacqui e solo moriro’. Bella frase, da allora non l’ho mai dimenticata. Racchiude la saggezza di un popolo che non teme la morte come noi, ma anzi la festeggia con allegria il 2 novembre. La celebra nelle canzoni popolari.
Noi invece cerchiamo mille modi per eludere il nostro orrore, cercando rifugio nelle religioni, sforzandoci di credere a storie inverosimili come quelle degli extraterrestri, degli spiriti, dell’amore di un altro essere umano ed altre baggianate. Ma non sarebbe tutto piu’ facile se imparassimo a convivere con la nostra solitudine, ad accettarla per quello che e’, ad apprezzarla per quello che vale? Si, per quello che vale. Ed oggi ne apprezzo tutto il valore.
Autore: Franco Garelli
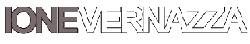
Scrivi un commento